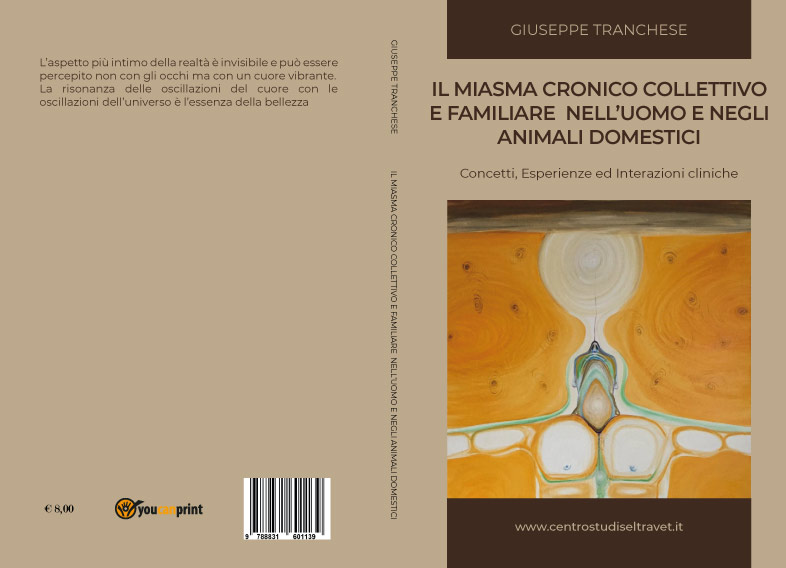di Giuseppe Tranchese
Proviamo a rispolverare, anche solo per un momento, una piccola parte della memoria storica bioetica, sociale e politica di homo sapiens, ovvero la nostra storia, e rivalutiamola sulla base dei risultati e delle conseguenze che abbiamo determinato sulla collettività vivente nelle varie epoche. Molto probabilmente saremmo costretti a cambiare la nostra tassonomia da homo sapiens ad homo rapiens. Infatti, per giudicare una civiltà, una religione, una filosofia ed anche un essere umano, esiste una cartina al tornasole: l’attenzione nei confronti di tutti gli esseri viventi ed il modo di preservarli dalle sofferenze. Sono numerosi gli eventi in cui è possibile rivedere analogie nelle sofferenze umane ed animali. Gli antichi romani, che hanno distrutto la fauna selvaggia dell’Africa del nord per riempire le loro arene, non hanno tardato a gettare, in quei crogioli della sofferenza, uomini, donne e bambini. Le sgozzature degli agnelli, in molte culture, sono andate di pari passo con l’escissione delle bambine e le lapidazioni delle donne adultere. Potremmo aggiungere la misteriosa e terribile relazione fra le plazas de toros e le atrocità delle guerre di Spagna (quella di Napoleone e quella di Franco); le similitudini tra gli allevamenti in batteria ed i campi di concentramento, tra i massacri della caccia di frodo (in particolare per la produzione delle pellicce) e quelli delle guerre. Basti pensare all’interminabile guerra in Afghanistan con il confronto tra due paesi in cui viene prodotto l’astrakan, pelliccia che si ottiene colpendo interminabilmente le pecore caracul per farle abortire e scorticando vivi gli agnellini appena nati. Si potrebbero, altresì, trovare collegamenti tra la vivisezione e le torture scientifiche, tra i sacrifici pseudo religiosi, le superstizioni, le magie e le mode. Un esempio, invece, decisamente positivo emerge dall’antica cultura greca. Gli antichi Greci, che seguivano l’oracolo di Delfi, poi ripreso da Platone, cercavano di mettere in pratica le due grandi verità: “conosci te stesso…” e “trova la giusta misura…”, anche nei rapporti con la natura. Infatti, a differenza dei Romani, non accettarono mai di costruire sul proprio suolo i circhi per espletare spettacoli-tortura.
Piuttosto che scomodare ingranaggi karmici di azione e reazione o contrappassi religiosi, un Sapiens dovrebbe sapere discernere e sconvolgere le frontiere tra categorie solo apparentemente distinte: natura e vita, corpo e spirito, animale e umano, partendo da “un’etica della vulnerabilità” per arrivare ad un “umanesimo dell’alterità”.
La sfida della bioetica è particolarmente difficile per il complesso rapporto tra il piano descrittivo ed il piano normativo: si tratta, infatti, di resistere a quel riduzionismo che vorrebbe applicare i soli modelli biologici, etologici e genetici alla società umana, pretendendo di prescrivere una morale ed una politica conformi ai soli dati scientifici. Invece, andrebbe soprattutto riconsiderato il modo in cui abitiamo la Terra e la condividiamo con gli altri viventi, gettando le fondamenta di un’etica della vulnerabilità sulle quali poter erigere le mura della cura. In senso stretto la vulnerabilità si riferisce ad una situazione di particolare fragilità dei soggetti che, per età e condizioni, necessitano di una particolare protezione, ma in senso lato riguarda la condizione stessa di precarietà di tutti i viventi che sono esposti, nell’arco della loro esistenza, al rischio di subire ferite di ogni genere, fisiche e morali.
Oggi viviamo una crisi ambientale, economica e sociale che evidenzia le profonde crepe del nostro modello di sviluppo, inconciliabili con la protezione della biosfera, con l’equità intergenerazionale e con il rispetto per le altre specie.
Dare centralità alla cura significa, in primo luogo, elaborare una visione etica incentrata sull’interdipendenza e sull’attenzione ad alcune categorie della vita sociale che strutturano la nostra esistenza, come genere, classe, razza e specie. In secondo luogo, significa proporre la cura come valore capace di informare la vita politica, in grado di rendere i cittadini più preoccupati dei bisogni del prossimo e più disponibili a porsi, empaticamente, dal punto di vista altrui, allargando le frontiere alla solidarietà ontologica dell’essere umano e della natura.
Se cura e responsabilità rappresentano gli elementi fondanti di un’etica della vulnerabilità, il suo nucleo essenziale è costituito dalla riabilitazione della “sensibilità”da intendersi come suscettibilità al dolore, al piacere ed al tempo (valicandoli) e come capacità di sperimentare la propria vita in relazione all’altro.
Un umanesimo dell’alterità, un pensiero dell’altro che mi riguarda. Dove per altro non indichiamo solo un altro uomo ma un qualsiasi altro vivente. Si tratta, certo, di un’alterità che chiede di essere interrogata e conosciuta, innanzitutto, come limite interno.
L’etica della vulnerabilità ci invita a riconsiderare i nostri rapporti con gli altri viventi perché si fonda su un’esperienza dell’alterità il cui nucleo è la presa in considerazione della sensibilità, della fragilità e della caducità di ogni essere, attraverso quello “sguardo muto”, empatico, che può avere la ricchezza di un vasto linguaggio, come soleva ripetere Martin Buber. Se intendiamo l’empatia come la capacità umana (e non solo) di immaginare la sofferenza e la degradazione di un altro essere come se fossimo noi a patirle, potremmo ravvisare in essa la scintilla che fa scaturire l’attenzione umana per tutti gli altri esseri viventi, rafforzando la conoscenza di noi stessi e la giusta misura delle cose tanto ambite dai Greci.
Non a caso Bertolt Brecht fa affermare con forza al suo Galileo: “Il cambiamento è da dentro o da nessuna parte”
Fonte:https://www.ildenaro.it/homo-sapiens-o-homo-rapiens/